La casa degli scemi di Anna Maria Farabbi, Lietocolle Ed., 2017, recensione di Milena Nicolini: dal terremoto della Grande guerra al terremoto nel Centro-Italia del 2016, l’impegno del canto di Anna Maria Farabbi.
E’ consueta Anna Maria Farabbi a scrivere in continuità di temi e problemi da un suo libro all’altro per rimandi più palesi o più sotterranei e con un dilatarsi della riflessione nella tessitura di una organica tela, la cui trama peraltro si accorpa anche fili vivissimi del concreto operare biografico della poeta. Così è da tempo che Anna Maria Farabbi si aggira nei meandri delle istituzioni totali, da quei manicomi e ospizi dell’orrore di leièmaria (Lietocolle, Como, 2013), all’ospizio femminile di Abse (Il ponte del sale, Rovigo, 2013), al manicomioarca di cui ci ha dato tanti frammenti in dentro la O (kammeredizioni, Bologna 2016), a questa casa degli scemi, che è il manicomio affiancato al fronte durante la prima guerra mondiale. E sempre intrecciate insieme ai libri ci sono le concrete esperienze con tanti esclusi, come l’incontro che continua tuttora coi matti ni della comunità a doppia diagnosi di Torre Certalda, o con le anoressiche, i sordi, i ciechi, gli ergastolani. Sono esperienze vissute da Anna Maria Farabbi con un io minuscolo, consapevole di una “propria relatività permanente”, capace di abbassarsi fino a terra per incontrare gli ‘ultimi’, quelli che la società ha lì relegato e così definito, dietro confini di separazione invalicabili. Esperienze vissute in poesia, perché Anna Maria Farabbi crede nell’energia della poesia, che è “eretica erotica eversiva”, a patto che i poeti scelgano di portare il canto ovunque, soprattutto “fuori dalle corti letterarie e dai palcoscenici”, perché la parola e l’azione della poesia possono tessere un rapporto intimo e profondo con “un qualunque tu”, anche un tu giudicato e relegato fuori dal consorzio civile; poeti in veste di recuperanti quindi – responsabilmente, umilmente, rispettosamente- recuperanti in primo luogo di un con-tatto con la comunità, e poi di una loro energia solare, se ancora possibile. Dice Bruno in La casa degli scemi: “leggevo la vena aurifera sul volto/ di un montone o del demente del villaggio/ o nel vuoto del mio io profondo”. Esperienze non concluse, ma aperte, di ampia prospettiva politica, civile, artistica, amorosa: in una poesia di dentro la O la poeta dice che il suo “polmone profondo” è “un nido/ dentro cui sordi matti ciechi/ uccellisenzaali sono entrati in me// come tutti i miei amanti”. Nel rapporto con il “qualunque tu” Anna Maria Farabbi c’è con l’intero suo corpo, “corpo in voce di poeta”, corpo “che attraversa inferni, campi e corpi, sigillati dalla società come inaccessibili e verso cui il sistema induce a rinunciare”. E’ così che la poesia si fa “opera”, cioè anche gesto verso un tu recuperato ad un’attenzione dignitosa, anche oralità che soffia in fiducia emozione tra bocca e orecchio, anche relazione tesa verso un noi reciprocamente responsabile. E l’opera è tutto, afferma tante volte Anna Maria Farabbi. Così come Bruno, il protagonista di La casa degli scemi.
Che è una vera e propria narrazione in versi, commista di brani in prosa, così come avveniva in Abse e in dentro la O, i due testi più prossimi a questo canto. Dai precedenti panorami molto ampi, corali, da quelle tessiture etiche, meditative, amorevoli, si arriva adesso a profili individualmente e storicamente determinati, attraverso i quali si incarna e sviluppa quella precedente riflessione e ricerca. Già concreti caratteri singolari comparivano nel manicomioarca di dentro la O e già la recentissima uscita dei testi più ‘caldi’ di Louise Michel (a cura e traduzione di Anna Maria Farabbi, è che il potere è maledetto e per questo io sono anarchica, Il ponte editore, Firenze 2017) proponeva insieme alle idee una figura a tutto tondo seguita nel lungo intero arco della sua vita. E già in Caro diario azzurro (edizioni Kaba, Pavia) 2013 si seguiva la vicenda di una bambina ebrea. Ma qui, e non a caso, il protagonista è raccontato in poesia. Con l’inquietante domanda – che spesso attraversa i testi di Farabbi anche se non si dovrebbe mai fare – se la vicenda è stata completamente vera anche nel mondo reale.
Bruno è un maestro ambulante, che insegna come l’antico Battista lungo il fiume a tutti quelli che lì vogliono o possono venire, negli anni che precedono la Grande Guerra. Anarchico, non ha mai avuto “la vocazione per gli umani”, forse per la delusione che non sappiano rinunciare alla “necessità della violenza come nella preistoria”, e che non abbiano la capacità di guardare senza le distinzioni tra ricchi e poveri, femmine e maschi, italiani e stranieri. Li tiene di là da un margine che si è tracciato intorno, entro il quale “io sono quel che sono”, dice. Che in qualche modo coincide col quaderno su cui traduce a mano il suo corpo. Eppure lui, “signore della sua acqua”, “signore del niente”, perfettamente coeso con la natura che gli sta intorno (“stanotte educo la testa/ la luce viola della luna mi viola la fronte”; “quando faccio terra sono terra”; “ho quel che mi basta fino al lusso di dormire per terra/ come il fiume”), non rinuncia a mettere “la sua vita alla mano/ di quelli che gli altri definiscono ultimi” e “non per cristo ma per etica”, e “per il senso civile di stare al mondo”, per “piantargli in corpo l’alfabeto”, indispensabile alla “creazione del pensiero che è necessità/ strumento precisione diritto alla sopravvivenza” e indispensabile per non sentirsi più servi. La passione politica però non lo avvicina mai agli altri, a contatto di pelle potremmo dire: “gli altri sono il confine”. Bruno insegna, spiega, discute, ma è solo, sta “per i fatti suoi”, “già di là dall’argine”, diverso da tutti gli altri umani; scrive con una matita rossa come il sangue quel quaderno in cui si sente davvero se stesso. All’annuncio della guerra, nella rabbia di doversi “consegnare/ dichiarandomi disposto a uccidere/ a perdere umanità e intelligenza rinunciando alla mia lingua/ con cui ascolto penso parlo riconosco e saluto/ quelli della mia stessa specie/ dentro la voce del verbo essere”, decide di arruolarsi volontario come barelliere della Croce Rossa, pur di essere “assente alle armi”, pur di non “rinunciare” a se stesso. La parte centrale del canto attraversa gli orrori di quella guerra così come abbiamo imparato a conoscerli da storici, testimoni e artisti, ma attraverso il vissuto di Bruno emerge soprattutto la rapacità con cui questa guerra “carnivora” violenta coscienza etica ragione, cominciando qui, dal fronte, nel mettere in atto una mattanza mai prima conosciuta e insensata, a sradicare freni inibitori fortissimi. Mentre leggiamo le righe di Bruno: “raccolgo bucce storte le rovescio le accatasto/ strappandogli la medaglietta dal collo/ che consegno al capitano/ i morti suonano”; “l’aria puzza/ i cadaveri ci infettano i cervelli”; “siamo diventati tutti anonimi”; “qui la nostra data di nascita è lo zero/ e coincide con la o della morte”, ci passano velocissimi in memoria i versi dell’Allegria di Ungaretti, la lucida disperazione di Un anno sull’altipiano di Lussu, la follia di Orizzonti di gloria di Kubrick con il gelo di quello che sappiamo avvenne dopo. Quei freni inibitori che la Grande Guerra ha rimosso dalla coscienza umana, come dice Hosbawm, lasceranno un vuoto che diventerà la terrificante disponibilità dell’uomo a violenze fino a quel momento inconcepibili. Come la Shoa, come le stragi etniche nell’ex-Jugoslavia, come l’11 settembre 2001. Ma Bruno è anche dentro o limitrofo ad alcuni di quei microepisodi che la storica Anna Bravo, in La conta dei salvati (Laterza, Bari 2013), porta a testimonianza di una diffusa, anche al fronte, volontà di nonviolenza: come il rifiuto dell’odio verso il nemico – “cerco” dice Bruno, di “uccidere in me la spontaneità dell’odio” – e un sentimento di vicinanza proprio “con quelli di là”, con cui si dovrebbe “riuscire a cantare” insieme, “se no dopo ogni guerra è guerra”. Soprattutto, Bruno comincia a sentire nell’orrore, nella sofferenza, nella disperazione una comunanza con i suoi compagni che a poco a poco intacca la sua individualissima chiusura, una fraternità “fra sangue, escrementi, pus, stracci luridi”, che Anna Bravo indica come “manutenzione della vita”, come attenzione di cura verso il corpo dell’altro, nello “scempio che spesso ne resta”, dal significato profondamente antibellicista più che genericamente cameratesco. Bruno, sempre più anonimo tra anonimi, fatica a ricongiungersi con colui che era, nemmeno scrive o apre il quaderno che testimonia la sua “misura di ieri”. Poi ferito gravemente, nell’esperienza dell’ospedale da campo finisce per perdersi del tutto in un inferno di orrore che non ha pausa mai, dove il dottore “ci assegna e ci spartisce come bestie da macello alla grappa/ all’amputazione al proseguimento della nostra morte in corso”. Inviato alla casa degli scemi per gravi disturbi psichici, luogo in cui più che curare si cerca di rimettere in sesto alla bell’e meglio i soldati per poterli rimandare al fronte il prima possibile, Bruno vive i maltrattamenti, le torture fisiche e psicologiche tipici dei manicomi, nell’abbruttimento dei farmaci e nell’annientamento umiliante di ogni forma di individualità e diversità. Finché, con in corpo “pochissimo io”, ma ancora capace di ribellarsi, e soprattutto “persuaso del plurale” che ha imparato nell’adesione intima al dolore di chi gli è profondamente compagno e non più un astratto “tu icona”, decide la propria uscita dalla “rete umana”, non per cedimento alla disperazione, ma “per mia dignità”. Muore “sul bianco della neve”, offrendosi come “cibo” agli animali, cancellando “biologicamente” dal cervello la “parola guerra” e tutti i suoi sinonimi, ma anche “leggero” e “convinto/ che la creazione è opera civile/ che sorge dalla consapevolezza del plurale” e che “le mie impronte fino a qui sono una marcia della pace”. Poi la pagina bianca. Il nulla, il vuoto della sua assenza. La continuazione è possibile solo tornando all’inizio del canto, quasi ad accentuare l’immenso silenzio che il corpo immobile di Bruno sulla neve lascia. All’inizio, infatti, si racconta che quel quaderno Bruno ha scritto di inviarlo ad un compagno di guerra, Luigi, di Arquata, ma anonimo come se non avesse nome, semplicemente uno dei tanti che erano al fronte. Il vecchio Tommaso, figlio di Luigi, ha perso tutto, famigliari e casa, nel terremoto del 2016, eccetto un nipotino lentigginoso dai capelli rossi e il quaderno di Bruno. Conosce Anna Maria Farabbi in visita ai bambini della tendopoli e la sente parlare contro la guerra. Le affida allora per una notte il quaderno di Bruno, poi lo brucerà nel falò rituale dedicato alla madonna. Lui, già morto coi morti del terremoto, lui sente che è il momento di far “uscire dagli uomini” il quaderno, ripetendo quasi le stesse parole e la decisione di Bruno. Perché ormai è avvenuto l’ultimo e più importante passaggio del testimone, implicito nel ruolo che Bruno ha assegnato al quaderno. Il quaderno è arrivato ad Anna, alla sua poesia, al suo lavoro di recuperante. Ad Anna che interviene qui con tutto il peso del suo reale impegno biografico, ad Anna che accetta come una missione, ricongiungendo il segno del rifiuto di Bruno, che era comunque insieme segno di fiducia e apertura verso il dopo, al segno di chi oggi, nel nostro problematico oggi, è disposto a credere nel noi.
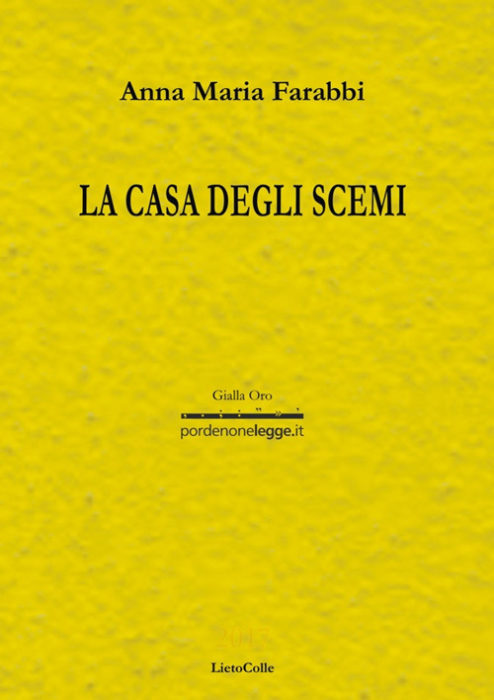


Come sempre l’analisi di Milena Nicolini, lega tutti i fili in un nodo che trattiene e ridistribuisce i movimenti scaturiti dalla lettura e dalle differenti, solo in apparenza però, percorrenze di Anna Maria Farabbi. Tutte le tematiche affrontate e i problemi snocciolati fino all’essenza mettono in luce la superficialità con cui affrontiamo a suon di mazzate date all’impazzata questo grande titano che è la vita, senza trarre dalla storia e dalle storie quanto invece potrebbe salvarci da una catastrofe che ormai recita i suoi tanti requiem.
Umanità, questo si chiede, facendo leva sul proprio mondo interiore, in un colloquio serrato e continuo con quanto di noi invece reprimiamo e non ascoltiamo per affrancarci a speculazioni che nulla hanno a che fare con l’una che dovremmo invece iniziare: l’osserbazione del cielo in cui stiamo navigando senza sapere quale sia la meta e cosa ci stiamo a afare qui perdendo tempo, un attimo dopo l’altro.
fernanda f.