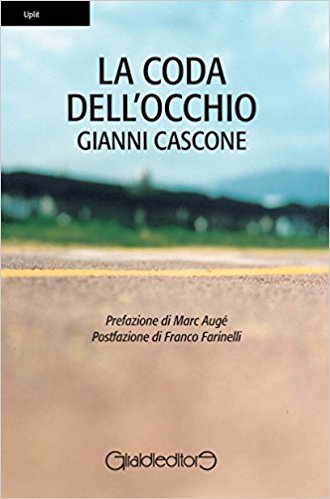PER FAVORE MI RACCONTI UNA STORIA?
racconto di Gianni Cascone
«Babbo,» si ritrova a dire Prokulo per la prima volta nella vita a quarantaquattro anni, «per favore mi racconti ancora la storia del kirghiso?».
«Sì» dice contento, anche se l’ansia lo abita sempre di più. E suo padre inizia a raccontare la storia del ‘ghirghiso’, come lo chiama lui spinto dal bisogno di una lingua scolpita che alla fine, per involontaria ironia, si mangia la coda e scade nella storpiatura.
«… durante la ritirata di Russia le truppe tedesche si erano portate dietro dei prigionieri. Con la divisone che era qui sull’Appennino c’era un poveraccio, un abbrutito che i Tedeschi trattavano come uno schiavo, facendogli fare i lavori più umili a calci nel sedere e buttandogli qualche avanzo, come si fa coi cani.
Faceva pena, anche perché nessuno lo capiva – parlava una lingua stranissima – e quando in paese si sparse la voce che gli americani di Clark stavano per arrivare» – qui, come, sempre gli si illuminano gli occhi – «tutti a gesti, in qualche maniera insomma, gli fecero capire di restare, di scappare dai tedeschi, di farsi liberare anche lui. E fece così.
Poi arrivarono gli americani, ma lui continuava a fare il barbone: viveva di elemosina, gli davano qualcosa ma nessuno riusciva a capirlo, perché parlava una lingua incomprensibile…
Dopo qualche mese succede che una pattuglia di indiani – perché, guardando l’Italia, per gli Alleati a destra c’erano gli Inglesi di Alexander con le truppe coloniali, e a sinistra gli Americani di Clark: è morto due anni fa, vecchissimo… –, insomma questa pattuglia di indiani che veniva su da Ancona invece di risalire lungo l’Adriatico sbaglia e viene verso il Tirreno, e arriva a Pavana. Entrano in paese con questi turbanti bianchi, questi baffoni neri, proprio sul mezzogiorno; allora si accovacciano tutti al bordo della strada a mangiare il rancio e mentre mangiano si scambiano qualche parola. E lui, il ghirghiso, è lì per caso… e vediamo che comincia a parlare, che si agita, e comincia a urlare, e a ridere e a piangere, perché con quelli si capisce, parlano lo stesso dialetto! E sembrava impazzire di gioia!».
Il Babbo sa raccontare la gioia, si vede che gli brilla sul viso aperto, e si commuove al questo riconoscimento nell’Epopea di una Vita.
«Parlavano un dialetto simile perché lui era del sud della Russia e loro del nord dell’India!» – ora che spiega gli sembra proprio il nonno… – «E lui partì con loro, e sarà tornato a casa!»
Di tante storie di guerra che il padre ha sempre raccontato, a Prokulo è tornata in mente proprio quella del kirghiso, come se fosse riposta nel fondo impensato della memoria. È successo guardando Bassem, l’amico libanese, insieme a Muin, lo scrittore palestinese.
Con l’amico si conoscono da venti anni (fan venti proprio adesso) e in tutto questo tempo hanno diviso tante cose, tante avventure, soprattutto gioie.
Ricorda il suo matrimonio, quando lo vedeva danzare nella sera d’estate, il fuoco negli occhi, con la sua sposa bella e bionda al ritmo incantatore di musiche arabe, mentre anche lui, un po’ malinconico, desiderava un giorno di essere felice così.
Ricorda quando, accovacciati nel buio del teatro accanto alle carrucole, facevano muovere le ali-quinte della grande “farfalla” che l’amico scenografo aveva inventato per lo spettacolo Senza; e gli scherzi di Bassem un po’ grassoccio a quei tempi (chissà perché, lui così longilineo) prima dell’entrata del pubblico – la barzelletta del cane che l’ha morso sul collo, la sua risata stridula e festosa che si spande e rimbalza nel Teatro Fabbricone…
Ricorda le nascite dei suoi figli, sempre immaginate nei racconti perché avvenute in Germania…
E poi gli spettacoli, lui che rimprovera Prokulo «Signor De Sade!» dalla balaustra del piccolo Teatro Magnolfi nella sua ‘bella’ giacca settecentesca (verde) da direttore del manicomio… e quel suo accento fransciose alla Inspector Clouseau… e poi lui, vestito da mago ne l’Illusion, molto charmant nel portamento, nello sguardo, nella parola, con le sue mani contadine; dopo è seduto al tavolo, travestito da vecchio, che cita le scene finali di Odissea nello spazio – Bassem è un grande attore – …e prima nell’Orpheus…
Ricorda lui che attacca il pane coi soldi e il sale sulla porta di casa ancora il giorno del suo matrimonio – ‘Dio, quanto ero felice per loro!’ pensa Prokulo…
E la festa di comunione del figlio prediletto in un bel ristorante di campagna nel Chianti, e le risate, le bevute, l’allegria, i nuovi amici…Ricorda le sue feste piene di gente – veri party! – nella casa di Firenze, vicino al giardino botanico con la grande serra ottocentesca, le prime volte che Prokulo assaggiava il tabule di prezzemolo, agro e appetitoso…
Ricorda quanti muri hanno restaurato insieme nei vecchi stanzoni industriali affittati per il loro gruppo culturale – Bassem gli ha insegnato a intonacare –, fino all’ultimo lavoro, con lui che salda le americane al soffitto – perché Bassem sa fare tutto, anche saldare!
Non dimentica che quando è stato talmente stanco da non sapere più dove mettere le mani l’amico gli ha sempre donato il suo aiuto.
E ricorda che l’ha visto fare i capelli bianchi per i familiari sotto le bombe in Libano. Laggiù dei militari invasori hanno bruciato una cassa con le poesie che lui aveva scritto in tutta la sua giovinezza, perché Bassem è un poeta epico, e quando Prokulo legge le sue poesie non resiste al pianto. Così ricorda che quando il figlio piccolo di Bassem ha rischiato di morire giocando sull’altalena, la sua forma di preghiera, nell’attesa della salvezza, fu un interminabile poema che lui andava componendo dentro e che non ha mai trascritto su carta. Le sue poesie nascono su foglietti microscopici, incasinati e consunti, piegati quattordici o quindici volte, che lui tiene nel portafoglio, raffinate rime arabe scritte di sbieco tipo su scontrini del bar…
E ricorda, con dispiacere, le sue parole amare sull’Italia, che disprezza perché non gli ha dato ancora la cittadinanza dopo venticinque anni di lavoro onesto – l’amico, come molti immigrati, vende le borse pur essendo un poeta e uno scenografo teatrale diplomato – o perché ci trova tanti difetti (le piccole mafie, la burocrazia, la corruzione di certuni nelle forze dell’ordine) e invece potrebbe essere il ‘bel paese’…
Tutto questo hanno vissuto e tanto altro, e Prokulo si è ritrovato nell’amicizia senza che mai si siano detti l’amicizia – potrebbe lui vivere senza Bassem?
Solo che Bassem ha sempre parlato poco, tanto che non si è mai lamentato dei problemi sul lavoro, delle preoccupazioni per i suoi cari in balia della ferocia di una guerra civile, delle sue infelicità. E via via che tutti insieme, loro amici del gruppo culturale, si sono allontanati dal teatro e si sono avventurati nella scrittura, il silenzio di Bassem si è fatto più denso, più esteso, fino a essere impenetrabile, a tratti quasi ostile.
Tante volte l’Amico, scostando la faccia e gettando uno sguardo triste, pieno di fastidio o di stanchezza, aveva detto a Prokulo, ossessivo mendicante bisognoso della sua poesia: «Ma che vòi?!… non c’ho tempo per scrivere… ma come faccio, c’ho da lavorare io, il banco, i campi…». Così alle riunioni settimanali del laboratorio di scrittura Bassem ha sempre partecipato quasi in silenzio, ascoltando, ascoltando, ascoltando ascoltando – perché lui è un grande ascoltatore; e un dolce saggio.
A tutto il gruppo ormai questo silenzio pesava, con il disagio di chi avverte l’imbarazzo impotente di non scalfire la reticenza di un tacere neanche con una goffa battuta, con qualche buffa provocazione che lui ha sempre vanificato assecondandole – Bassem è furbo e intelligente.
Poi un giorno è arrivato Muin.
Muin è uno scrittore palestinese e lo avevano invitato in città per il progetto sulle forme del narrare, ideato per conoscere le culture straniere. E insomma arriva lo scrittore palestinese: è alto, moro con i capelli corti, gli occhi scuri e un fisico da atleta, ‘bello come un greco’ dicono le donne del laboratorio, tutte eccitatine. Muin, con il calore innato dell’uomo levantino e una umiltà da letterato tutta sua, forse assorbita dall’ambiente torinese in cui è innestato, nella sala dell’antico palazzo dove lavorano comincia a dire del suo paese oppresso dalla violenza israeliana, dei suoi primi racconti in italiano sparsi per internet, della sua amicizia con un altro scrittore torinese che lo ha scoperto chattando in rete, quando ignoravano di lavorare nella stessa azienda a due piani diversi, uno sulla testa dell’altro… storie curiose… simpatia naturale da parte di tutti verso questa persona.
Bassem come sempre ascolta e tace, e osserva con quel suo sguardo curioso e calmo, sensibile ma distaccato a cui raramente sfugge qualcosa; anche perché – Prokulo s’immagina a ritroso – vuole capire bene, dato che i libanesi non amano i palestinesi: come gli spiegherà dopo, sono ritenuti un po’ i responsabili del conflitto che ha distrutto il Libano, o almeno l’elemento scatenante della guerra civile.
Finché lo scrittore, dotato di una medesima sapienza e incalzato dalle domande del gruppo, piano piano risale all’indietro, agli anni della scuola, dell’adolescenza. E a un certo punto racconta che aveva da sempre scritto un diario, ma quel diario, in cui erano riposti tutti i sentimenti i ricordi e le speranze, lo aveva distrutto.
«Sentivo che era pieno di odio» dice.
Prokulo potrebbe ammettere che non ha elementi di prova, ma è ugualmente certo che in quel punto, all’incrocio di quelle parole, la strada dell’amico libanese ha incontrato quella dello scrittore palestinese. Da lì in poi hanno cominciato a scambiarsi sempre più spesso battute in arabo, la loro medesima lingua per gli altri del tutto incomprensibile, e di momento in momento, come si potrebbe dire dell’intesa segreta fra due amanti, Muin a ogni frase cercava lo sguardo di Bassem e nei punti cruciali il suo consenso; mentre Bassem, il silenzioso, ha iniziato a entrare nei discorsi di Muin e, quasi senza più senso della misura, a narrare il suo paese, le feste, le usanze, la sua infanzia. E si vedeva che era in preda a un’eccitazione che era sconosciuta al gruppo, simile a quella di un fiume sotterraneo che trova lo sbocco per emergere e zampillare. Gli altri si guardavano stupiti, felici e stupiti, cercando di capire dov’era che si erano incontrati, e quando; e qualcuno, con dolce ironia, come sul luogo di un miracolo, faceva notare a Bassem che stava parlando, che lui stava rompendo un silenzio che durava da mesi, forse anni – chi sa più nei cicli del cuore.
La sera dell’evento, quando Prokulo si è ritrovato nella calma della camera, alla gioia del ‘ce l’hai fatta, Amico, ce l’hai fatta!’ è subentrata una tristezza profonda. Perché gli è venuto spontaneo chiedersi del perché lo scrittore così facilmente avesse trovato la chiave per aprire la teca di silenzio in cui Bassem si era rinchiuso.
«Sì, certo» diceva a sé stesso, «parlano la stessa lingua, sono di una cultura più simile». Ma poi sentiva che il gruppo aveva toccato davvero quello che significa l’appartenenza a una terra, l’essere nati sotto lo stesso sole, circondati da uguali odori, immersi in un paesaggio e un’atmosfera che sono proprio quelli, con quei colori e non altri; quella sensazione di improvviso benessere del corpo che lui ha visto nei racconti di ritorno degli emigranti, e in sé stesso quando è potuto tornare nel suo paesaggio di pianura, quello in cui si immaginava e si sentiva nato.
Solo che adesso, nel riconoscimento reciproco dell’amico e dello scrittore, Prokulo sentiva per la prima volta come un profondo senso di colpa, tutta la sua incapacità di chiedere nel modo giusto quella storia, nelle parole di Bassem.
All’amico non aveva saputo chiedere, forse addirittura non aveva mai chiesto; come a suo padre, a sua madre – e anche a se stesso – una storia (le sue storie): quella incapacità bruciava come la ferita di una vergogna e di una colpa, da amico inospitale.
Poi lo scrittore è partito, gridando in arabo a Bassem che non doveva finire lì, che le loro famiglie dovevano incontrarsi. L’amico gli aveva scritto una dedica sul libro, che poi era una poesia – sì, Bassem era tornato a scrivere! – e prima aveva voluto leggerla a Prokulo, per sapere se andava bene: lui, maestro di poesia! (già una consolazione…). Allora si è messo a piangere – fuori pioveva – e con tenera stizza ha detto «Ach, non riesco a leggere qualcosa che ho scritto senza commuovermi» mentre gli occhi a Prokulo versavano dentro, sulle ossa, le lacrime per la sua lontananza da casa, per la violenza che la vita ci usa, per la gratitudine di questo momento di intimità che il destino donava, e per la disperazione di un ritorno che non potremo mai compiere.
Ora che sono passati dei giorni, la ferita della vergogna, un po’ come tutto, si va cicatrizzando e Prokulo si illude che il fiume di ricordi dell’amico era comunque destinato a uscire, forse proprio qui, nel tempo che i suoi bambini vanno crescendo come le viti nuove che ha piantato in questo paese – la ‘nostra’ terra? – e che cominciano a dare frutti.
Fra pochi giorni festeggeranno il suo cinquantesimo compleanno – Bassem ha cinquant’anni!
Gli ha preso un regalo: Prokulo sa per certo che senza il suo Amico non può vivere.
____________________________________________
Il racconto è tratto dalla raccolta La coda dell’occhio, di Gianni Cascone, prefazione di Marc Augé – postfazione di Franco Farinelli, Giraldi 2016. Ringraziamo l’autore e l’editore che ci hanno consentito la pubblicazione.